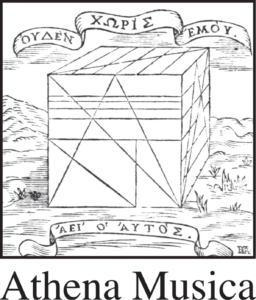domenica 27 aprile 15:00 - 19:00 - Spazio convegni - Salone dell'Arco - Padiglione Monumentale
La tavola rotonda, promossa da Athena Musica e coordinata dal Dr. Francesco Finocchiaro, affronterà il tema del “restauro musicale” espressione divenuta d’uso comune per riferirsi a operazioni che si collocano in una terra di mezzo tra filologia, creatività e tecnologie applicate. S’intendono con cioè quei tentativi di divinatio del musicale a partire da fonti lacunose in parte o in toto: completamenti di “incompiute”, ricostruzioni di porzioni d’opera mancanti, integrazioni di lacunae, fino alla rigenerazione vocale e alla produzione ex novo di brani “alla maniera di”. Parlare di restauro musicale dà patente di rispettabilità a operazioni creative, didattico-divulgative, commerciali, che sollevano tuttavia non pochi quesiti epistemologici, estetici ed etici. Questi nodi da sempre problematici, destinati ad assumere rilievo ancor maggiore nell’era dell’intelligenza artificiale, saranno messi a tema nella tavola rotonda.
Programma:
Massimo Raffa, Lacune sonanti. Colmare i vuoti nelle melodie dell’antica Grecia
Delle poche decine di melodie che ci giungono dall’antichità greca, tutte, tranne una, sono più o meno frammentarie. Chi voglia eseguirle per riportarle in vita deve, quindi, colmarne le lacune, cioè compiere quel salto immaginativo che i filologi chiamano, non a caso, divinatio e che sono in genere restii a compiere, poiché lo considerano una pratica ai limiti della scientificità. Il contributo prende in esame alcuni casi di melodie lacunose e descrive i modi in cui si è tentato di restaurarle.
Chiara Bertoglio, Il dilemma del restauratore tra Bach e Busoni
Nella sua edizione del Clavicembalo ben temperato, l’empolese F. Busoni suggerisce di apportare modifiche al testo bachiano per trasformare alcuni Preludi in Studi. Non sempre, però, tali indicazioni sono sufficienti per ricostruire una versione dell’intero Preludio/Studio. L’interprete odierno si trova perciò a decidere se completare le parti mancanti “in stile busoniano” per non creare una discontinuità nell’esperienza di ascolto, o se tornare in tali occasioni al testo bachiano. Un dilemma da restauratore, reso ancor più complesso dalla presenza di tre “autori” (Bach, Busoni, e l’interprete) e dalla fruizione temporale della musica. Unn dilemma che la stessa persona può risolvere in modi diversi a seconda che si trovi a suonare in pubblico, incidere un disco o pubblicare un’edizione critica, come verrà esposto durante la presentazione.
Graziella Seminara, Fedeltà e creatività nel restauro drammatico-musicale: il caso Turandot
Turandot di Puccini, Doktor Faust di Busoni e Lulu di Berg si possono annoverare tra le grandi opere incompiute del XX secolo. Si tratta di tre case studies di grande interesse, ma quello dell’opera pucciniana appare esemplare delle problematiche poste dal “restauro” di una partitura teatrale non ultimata. L’opera è stata proposta tanto nella versione originale priva di finale (in occasione della prima rappresentazione scaligera del 25 aprile 1926, con Toscanini alla direzione) sia con la ricostruzione del finale da parte di due diversi compositori (Franco Alfano, che ne diede due versioni, e Luciano Berio). Se la duplice declinazione della messinscena pone il problema della legittimità del completamento di un “testo” musicale destinato al teatro da parte di un compositore altro dall’autore, il duplice rifacimento del finale di Turandot consente di constatare come il diverso approccio all’operazione di integrazione non solo rifletta l’orizzonte culturale dei due musicisti coinvolti ma si riverberi sul senso stesso del “lieto fine” della vicenda drammatica.
Francesco Finocchiaro, (Ri)comporre per il cinema muto
I film muti non sono mai stati così di moda come oggi. Il cinema muto vive da qualche anno una vera e propria renaissance: un interesse crescente sul piano storiografico e (forse soprattutto) da parte del mercato. Ma là dove ci sono film muti, ci sono accompagnamenti musicali: se è vero che il cinema muto è al centro di una renaissance, la musica può dirsi parte integrante di questariscoperta. Negli ultimi anni si è assistito a un exploit dell’esecuzione, composizione e produzione di musiche d’accompagnamento alla proiezione di film muti. Gli accompagnamenti musicali per il muto hanno dato vita a una industria di successo, fatta di tournées di concerti dal vivo, festival internazionali, produzioni in DVD. La musica d’accompagnamento per il cinema muto rappresenta un settore produttivo attuale e vivace come pochi altri: un promettente campo di attività per musicisti in grado d’improvvisare, di sperimentare, di ricostruire su basi filologiche la musica di un film o comporne una analoga a quella che si sarebbe potuta udire ai tempi dell’uscita di unadata pellicola.
Stefano Lombardi Vallauri, Pseudo-restauro parassita: da Made in Heaven dei Queen a Now and Then dei Beatles
La possibilità mediante la tecnologia di creare-completare opere d’autore, di cui manca però l’autore stesso, solleva delicate questioni. Chi è l’autore di un’opera realizzata col parziale contributo di un autore non vivente? Si può definire un restauro quell’opera, poiché ripristina la volontà dell’autore, anche se solo presunta? I realizzatori viventi di quell’opera ne detengono giustamente tutti i diritti economici? Casi come l’album del 1995 dei Queen viventi, ma postumo di Freddie Mercury, o come la versione “naked” di LetIt Be dei Beatles, o come – ancora a firma loro – il recentissimo brano Now and Then, vincitore addirittura del premio Grammy per la miglior performance rock nel 2025, ma “performato” da John Lennon nel 1977, sono in apparenza restauri, in quanto recuperi di un’impronta autoriale originale, tuttavia disintegrano la nozione di autenticità dell’opera d’arte.
Intervengono:
Dott. Francesco Finocchiaro, Dott.ssa Chiara Bertoglio, Dott. Stefano Lombardi Vallauri, Dott.ssa Graziella Seminara, Dott. Massimo Raffa.